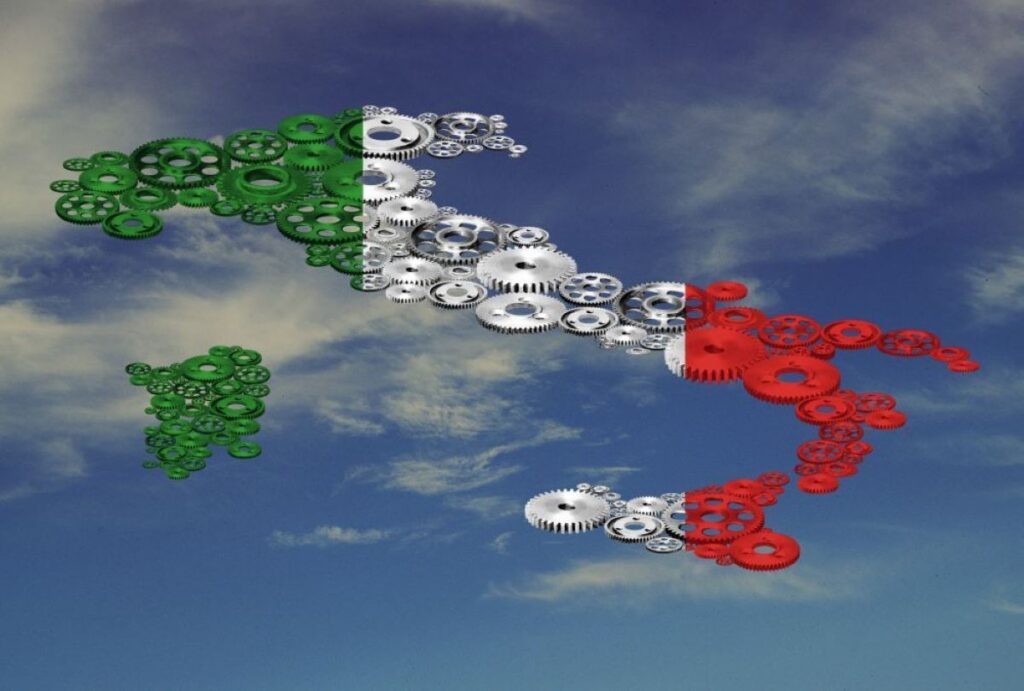di Giuseppe DE LORENZIS
L’acceso dibattito sulle autonomie delle Regioni non è una novità: se si approfondisse il tema ci si accorgerebbe che la questione, seppur con le variegate sfumature dovute ai contesti storici diversi, esiste già da più di un secolo e mezzo.
Le prime dispute sulle autonomie regionali risalgono agli albori dell’Unità d’Italia: appena fatta l’Italia, se da un lato Massimo D’Azeglio auspicava che dovevano essere fatti anche gli Italiani, dall’altro il Governo Cavour sin dal 1860-61 si faceva portavoce di un disegno, ideato dai ministri dell’Interno Farini e Minghetti, con lo scopo di conciliare la varietà regolamentare, esistente in diverse parti d’Italia, all’unità legislativa della Nazione.
Il progetto prevedeva la formazione di consorzi interprovinciali chiamati REGIONI, rette da un Governatore dipendente dal Governo e da una Commissione eletta dai Consigli Provinciali, con poteri deliberativi in materia di istruzione superiore, caccia e pesca, bonifiche fondiarie, opere pubbliche.
La proposta, pur particolarmente blanda e cauta, non ebbe il favor della Commissione della Camera che si oppose fermamente, ma il dibattito continuò ancora per circa sessant’anni, contrapponendo i difensori dell’autonomia a coloro che invece la osteggiavano.
I primi sostenevano l’idea di garantire la libertà locale, in origine per evitare la “piemontesizzazione dell’Italia”, poi per contrastare l’invadenza dello Stato-persona, ma di fondo per adeguare le strutture amministrative alle diversificate condizioni del Paese (del Sud in particolare), rendendo così più efficiente il funzionamento dell’apparato statale e gli amministrati più vicini all’azione amministrativa. Si affermava financo che ciò avrebbe comportato la riduzione della spesa pubblica e degli squilibri derivanti dalla diversa ricchezza e dal diverso sviluppo esistente tra le varie zone dell’Italia.
D’altro canto, i contrari vedevano grossi pericoli per l’appena conquistata unità, nel contempo si temeva che l’istituzione di un ente sovraordinato agli apparati amministrativi locali già esistenti, quali le Province e i Comuni, potesse, al contrario portare a una centralizzazione a scapito degli enti sottordinati, o ancora a un aumento della spesa pubblica per la necessità di dover sopportare i costi della moltiplicazione degli enti. Gli antiregionalisti dell’epoca adducevano anch’essi la presenza di rilevanti squilibri regionali, particolarmente sentiti dagli studiosi e dai politici meridionalisti che propugnavano, più che la concessione di nuove autonomie, l’intervento diretto dello Stato-persona sul modello della Legge del 1885 per la città di Napoli.
Senonché, prima di vedere introdurre nell’ordinamento italiano il termine “Regione” nell’accezione attualmente intesa, bisogna attendere il 1921, allorquando si disciplinò il riassetto amministrativo dei territori del Trentino-Alto Adige e della Venezia Giulia, annessi al Regno d’Italia dopo la I guerra mondiale, con provvedimenti che concessero apposite “autonomie regionali” oltre che provinciali e regionali, destinate ad essere attuate non solo sul piano dell’amministrazione, ma anche attraverso l’esercizio di poteri legislativi spettanti alle diete provinciali sopravvissute alla dissoluzione dell’Impero austro-ungarico.
La discussione sulle autonomie regionali continuò negli anni successivi e, eccettuato il periodo del ventennio fascista durante il quale esse non potevano trovare adeguata collocazione anche per ovvie ragioni politiche, già sotto il primo governo Badoglio si tornò ad affrontare nuovamente il tema.
Esso venne sollecitato anche dalla necessità di affrontare il problema delle istanze separatistiche che giungevano a gran voce dalla periferia dello Stato Italiano. Così si dispose già nel 1944 una “Consulta Regionale” per la Sardegna e successivamente l’approvazione dello Statuto Regionale Sardo con legge costituzionale nel 1948. Più rapida l’approvazione dello Statuto Speciale per la Regione Siciliana, dalla quale si sollevavano fermenti autonomistici e separatistici: lo statuto venne approvato nel 1946.
Lo stesso timore del separatismo portò alla speciale concessione di autonomia nella Valle d’Aosta nel 1945. La tutela della minoranza linguistica tedesca condusse nello stesso periodo all’accordo italo-austriaco De Gasperi-Gruber, concluso a Parigi il 5 settembre 1946, con il quale agli altoatesini venne riconosciuto il diritto di usare la lingua materna nelle scuole e negli uffici, oltre a un’autonomia legislativa e amministrativa coincidente con l’area abitata dalla minoranza stessa.
Quindi, dopo il secondo conflitto mondiale, i nostri Padri Costituenti dovettero affrontare le autonomie delle Regioni, fatto ormai compiuto per quelle a Statuto Speciale, mentre rimaneva tabula rasa l’elaborazione di un progetto regionale riguardante il rimanente territorio italiano.
Durante i lavori dell’Assemblea Costituente nell’immediato dopoguerra, diverse furono le tesi che appassionarono gli studiosi: dalla proposta federalistica dei repubblicani di un’Italia suddivisa in 5 o 6 cantoni, a quella dei liberali e degli azionisti di riconoscere autonomie regionali conciliabili con l’unità dello Stato, fino a quella assolutamente contraria alle autonomie sia perché costituenti un rischio per lo Stato unitario, sia perché in grado di compromettere lo sviluppo di una pianificazione economica a livello nazionale, cara ai comunisti dell’epoca. Nessuna posizione, comunque, particolarmente incisiva.
Gli atti dell’Assemblea ci restituiscono un’incertezza negli orientamenti dei costituenti in tema di autonomie e ciò fino all’estate del 1947, allorquando il titolo V del progetto di Costituzione, redatto da un ristretto Comitato speciale per le autonomie locali, venne esaminato.
Iniziò un fervente dibattito in cui cominciarono a vedersi repentini cambiamenti di fronte: dai liberali che si spostarono verso una posizione antiregionalistica, all’estrema sinistra che, estromessa dalla coalizione di governo, si convertì improvvisamente alla difesa dell’autonomie regionali, considerate un ostacolo allo strapotere del governo dal quale era stata esclusa. Nel mezzo i democristiani che assunsero posizioni garantistiche della libertà locale.
In realtà, l’approvazione del titolo V della Costituzione, relativo alle Regioni, fu il frutto di compromessi e fu estremamente ambiguo e lacunoso tanto che Salvemini concluse che si trattava di un “vaso vuoto con sopra la targhetta Regione”.
Tant’è che le Regioni sono rimaste pressoché sulla Carta (Costituzionale) per quasi trent’anni prima di trovare attuazione, a partire dalla metà degli anni ’70, mediante l’approvazione delle leggi che ne disciplinassero il funzionamento e l’elezione dei Consigli, nonché il trasferimento delle funzioni amministrative.
Sotto una continua spinta autonomistica, si giunse nel 2001 alla riforma degli artt. 116 e 117 della Costituzione. La modifica di tali articoli, frutto di un procedimento complesso, garantito e rinforzato da un quorum maggiore rispetto al normale richiesto per l’approvazione delle leggi ordinarie, venne confermata da un referendum. Fu un primo nuovo passo verso un’autonomia regionale più incisiva rispetto al sistema previgente.
La riforma degli artt. 116 e 117 della Costituzione rappresenta l’incipit, l’ambito di movimento e il perimetro dell’agire, presupposto imprescindibile e necessario senza il quale oggi non avremmo visto sorgere l’attuale legge sull’autonomia differenziata delle Regioni, che ne costituisce l’attuazione.
Alla luce delle critiche e polemiche oggi agitate dagli schieramenti di opposizione, contrari all’autonomia differenziata, desta stupore constatare che la revisione del Titolo V della Costituzione, con la modifica degli artt. 116 e 117 in evidente chiave autonomistica, fu approvata dal Parlamento tra il 28 febbraio e l’8 marzo del 2001 con i soli voti del centrosinistra, mentre il centrodestra non partecipò per protesta, ritenendo che una riforma di simile portata non potesse concepirsi negli ultimi mesi di una legislatura ormai prossima al termine, con le imminenti elezioni politiche fissate al 13 maggio 2001.
L’attuale dibattito sembra quasi un rinnovarsi, per corsi e ricorsi storici, degli scontri che avevano animato, sebbene sotto differenti contenuti normativi, le contrapposizioni politiche postunitarie e postbelliche in ordine alle autonomie regionali, con alternanza di vedute apparentemente contraddittorie da parte dello stesso schieramento politico, oggi come allora, prima per sostenere, poi per contrastare: nihil sub sole novum.
Ma non era forse ragionevole attendersi che quel vaso vuoto dei Padri Costituenti sarebbe stato man mano colmato? Se mezzo vaso era stato riempito dopo circa trent’anni dalla Costituzione, non era logico aspettarsi che la rimanente parte del vaso (mezzo vuoto) potesse essere colmata prima o poi con l’attuazione degli articoli 116 e 117 della Costituzione?
Si trattava, in buona sostanza, di dare contenuti alla riforma che altrimenti sarebbe rimasta una vacua chimera sulla Carta (Costituzionale) anche qui, ora come allora.
Le posizioni favorevoli e contrarie, come da tradizione storica, oggi si contrappongono ancora una volta per rappresentare gli annosi problemi: da un lato maggiore efficienza, miglioramento dei servizi e vicinanza delle istituzioni al territorio e ai cittadini, dall’altro i rischi di disgregazione della coesione nazionale e di crescita del divario tra il Nord e il Sud.
A ben vedere, il divario tra il nord e il sud del Paese esiste da sempre e, finora, non si è mai fatto nulla per ridurlo: per curarsi al meglio i meridionali scelgono quasi sempre di spostarsi fuori Regione, al Nord; le migliori risorse del Meridione emigrano per le difficoltà e le scarse opportunità nel proprio territorio. Si calcola che nel 2080 (rapporto Svimez) la popolazione al Sud diminuirà di circa 8 milioni di abitanti, ovvero sarà esattamente la metà di quella di oggi.
Claudio Velardi in un suo recente articolo ha scritto: “Posare gli occhi per terra significa partire dal Sud per quello che è. Io nel Sud ci vivo, il Sud lo conosco, me lo porto addosso come una seconda pelle. Nel Sud la vita è più faticosa e scomoda che al Nord: i servizi essenziali (sanità, trasporti, infrastrutture, macchine burocratiche) non funzionano, la formazione è scadente, i livelli di reddito sono più bassi. Dal Sud quelli bravi vanno via. Ora. Senza l’autonomia differenziata. Guardare la luna significa gettare le basi per una rivoluzione del Sud, fondata sulla responsabilità dei cittadini e dei governanti, sull’autogoverno delle sue comunità, sulla valorizzazione delle sue risorse. Senza andare con il cappello in mano ad elemosinare a Roma. I politici, gli intellettuali e gli opinionisti che guardano il dito organizzino pure vibranti proteste e referendum, i meridionali che guardano la luna si battano per cambiare il corso delle cose, con orgoglio e dignità.”.
La legge sulle autonomie differenziate delle Regioni appena approvata si inscrive in un quadro generale in cui, in ogni caso, appare salvaguardato il rispetto dei princìpi di unità giuridica ed economica, nonché di coesione economica e fermo restando che l’autonomia e le attribuzioni richieste dalle Regioni sono subordinate all’approvazione della disciplina relativa ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale. I LEP costituiscono una soglia minima per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale.
L’iniziativa per ottenere l’autonomia differenziata (su 23 materie ben specificate) deve partire dalla Regione interessata che deve concordare un’intesa con lo Stato. Il Presidente del Consiglio dei ministri al fine di tutelare l’unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, può limitare l’oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell’atto di iniziativa.
Se questi sono i principi e se si colgono gli aspetti di garanzia di unità e coesione, nonché di rispetto dell’equità dei diritti civili e sociali, probabilmente sarà un’importante opportunità affinché ogni Regione, specie al Sud, lungi dall’essere abbandonata a sé stessa, permanendo pur sempre il principio solidaristico, possa trovare
uno slancio per creare le condizioni ottimali per lo sviluppo e la crescita del proprio territorio in piena autonomia.
Vedremo cosa ci riserverà il futuro.